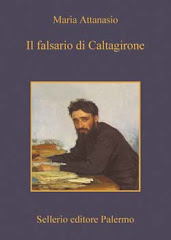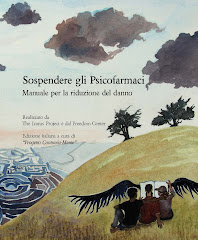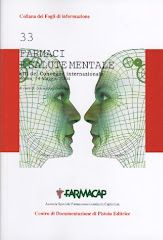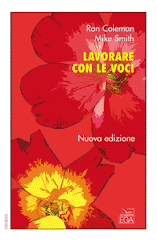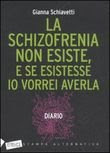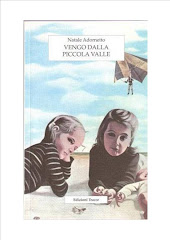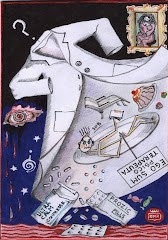«Scomparsa da lungo tempo la malattia» che in Puglia «era
basata più nella disposizione malinconica degli abitanti della Italia meridionale,
che sulla natura del veleno della Tarantola, che deve senza dubbio esser
riguardato come causa remota del male, che senza la disposizione indicata
sarebbesi rimasta inefficace.» Così aveva concluso già nel 1832 G.F.G. Hecker, medico
plurititolato presso l’Università di Berlino come della Pontiniana di Napoli.
In modo molto affine aveva concluso Ernesto de Martino nel 1961 dopo una ricerca
etnografica condotta nel Salento alla fine degli anni Cinquanta. Il veleno
causa remota di una malattia, scomparsa già negli anni Trenta e, a dire
dell’intellettuale, quindi impossibile ritrovare nel 1959.
Nella letteratura, più o meno scientifica, che tratta di
Tarantolismo, la Tarantola
è proprio ballerina. Sfuggente ad ogni tavolo anatomico come ad un’attenzione
entomologica che in molti tra gli studiosi non avevano, per alcuni era
responsabile del fenomeno per altri no, mentre altri ancora la dichiaravano
irresponsabile dove una pagina prima l’avevano vista perfino mordere se non pungere.
Un andamento altalenante e ambivalente sono in tanti gli scrittori a
mantenerlo; sicuramente lo mantiene anche De Martino ma non era il solo: è come
se ognuno che scrivesse di Tarantola, oltre a ridurla a “taranta”, già snaturandola nel suo essere, non si sentisse il
coraggio di dichiarare idiozia quanto avevano precedentemente scritto i
colleghi studiosi, dei quali aveva bellamente corredato la propria
bibliografia, mentre era quello che realmente pensava. Un attimo dopo, sentite
i cheliceri sulla propria pelle, ritornava l’atroce dubbio: punge o non punge?
Quando volevano dire, ma non sapevano dirlo, che pungeva, qualcuno incominciava
a parlare di “morso”, variando così
tutta la meccanica puntoria e chelicerica del ragno, e di “taranta” riducendo il ragno ad animale simbolico, privato dei suoi
cheliceri, del suo veleno e della sua mala abitudine ad andare pungendo la gente.
Lungi dal voler ridurre un fenomeno complesso come il
Tarantolismo ad un suo qualche emergente o intrigante elemento, la Tarantola quando può
continua a pungere.
Di recente i dottori S. S. Colonna e M. Garofalo,
dell’Ospedale Provinciale “Cardinale G. Panico” di Tricase (Lecce) riscontrano
in una persona arrivata all’attenzione delle loro cure una “Sindrome rabdomiolitica” da puntura di
ragno, la curano e la dimettono. Si tratta del sig. Oronzo che è rimasto
solamente una persona punta da una Tarantola e non è stato mai definito, né mai
diventato un tarantolato né tantomeno considerato tale. Alcuni suoi parenti,
riscontrati in anamnesi punti dalla Tarantola anni prima, sono stati definiti “tarantolati” e sono diventati “tarantolati”. Se la sintomatologia nel
tempo è rimasta di una certa stabilità e costanza è cambiata la diagnosi da “Tarantolato” a “Tarantato” a “Sindrome
rabdomiolitica” da puntura di ragno. Non è detto che al cambio di diagnosi
debba necessariamente seguire un cambio di trattamento.
I trattamento oggi riservato ad Oronzo non c’era fino ai
tempi di De Martino e i tarantolati autocreavano e ricevevano le cure di cui
erano a conoscenza per averle sperimentate da millenni. Era certamente
paradossale che se vivevano costretti in subalternità, esclusione, abiezione e
miseria nera all’interno di una relazionalità autoritaria, relativamente alla
cura e alla terapia di quella che per loro era un’atroce sofferenza, avessero
imparato a fare da loro stessi e lo facevano da millenni in un clima di
solidarietà, comunitario e autogestionario dove, l’etnologo, nel 1959, a fianco della
Musicoterapica e della Danzaterapia da tempo immemore terapie ufficiali per
molte malattie, aveva riscontrato la “Santoterapia”:
quella cura che, dal medico Asclepio, si proiettava direttamente su San Paolo
assunto all’interno di una relazionalità che, criticabile per quanto si voglia,
aveva una funzione terapeutica per quel tipo di sofferenza. Sicuramente più
terapeutica di quanto non riusciva ad essere la Neuropsichiatria
in pieno Manicomio.
Troppe dicerie, tra superstizione e religione, De Martino
aveva deciso di porre fine alle frottole secolari che comunque sembra gli studiosi
precedenti non erano stati in grado di evitare: il simbolo agente di un ragno
simbolico scatenava nel corpo di chi veniva punto tutta una sintomatologia e
una sofferenza per attenuare la quale si ricorreva alla musica, alla danza e ad
un gioco di colori. Isterismo? Forse, anche se lo stesso Hecker aveva
chiaramente differenziato i due fenomeni sostenendo perfino che l’Isterismo,
per le sue tendenze imitatorie, inquinava il Tarantolismo. Intanto De Martino
sosteneva d’aver capito che erano le donne a ricevere più facilmente degli
uomini un “morso” di “taranta”; perché queste erano portatrici
di un conflitto psicologico irrisolto scalpitante nelle nere segrete
dell’inconscio che, per evitare, da un momento all’altro, che potesse esplodere
in un comportamento sociale non più controllabile, trovava orizzonte di
risoluzione in quel comportamento da lui definito “Tarantismo”.
Com’è che quel simbolo del ragno, della Tarantola, con
tutta la sua gravità deterministica, simbolo agente fino a qualche anno fa,
ora, nel caso di Oronzo, ma non solo, è stato totalmente ignorato, escluso,
squalificato? Non esiste proprio più. Perché Oronzo, uomo e non donna, è
portatore di una puntura di Tarantola e non di un conflitto psicologico
irrisolto? Secondo le conclusioni di De Martino in un errore sarebbero potuti
cadere questi medici dell’ultim’ora: trattandosi di un conflitto psicologico
irrisolto, il loro intervento per sindrome rabdomiolitica, oltre che
inappropriato, evitando un deferimento del paziente alla Neuropsichiatria,
avrebbe rischiato di spingere il malessere di Oronzo verso un comportamento non
più gestibile socialmente. Verso un comportamento folle.
La Tarantola
aveva punto da sempre e continuava a pungere. Se di Medicina si poteva parlare,
quella popolare si muoveva tra mitologia, tradizione, religione, superstizione.
Chi veniva punto, al di là del sesso e dell’età, altro non desiderava che
salvarsi, anche se non se la poteva garantire, quel poco della pelle e della vita
che gli rimaneva.
L’etnologo De Martino sostiene che, forse, una volta ci
sarà stata qualche puntura (“morso”)
di ragno, qualche caso di reale Latrodectismo, a patire dal quale, col tempo,
si incominciò a plasmare il Tarantismo da lui osservato nei residui: un fenomeno durante il quale le
persone si comportavano come se realmente fossero state avvelenate dalla Tarantola
mentre non erano state nemmeno punte.
Leggendo il libro di Ernesto De Martino, La terra del rimorso: contributo a una
storia religiosa del Sud, il lettore alla fine, tra puntura sì e puntura
no, si vede costretto a chiedersi: ma questo ragno punge o no? È velenoso o no?
Se il ragno non punge, tutta la sintomatologia raccontata e descritta da
millenni da dove mai deriverebbe? Proprio quella sintomatologia che oggi sembra
trovare accoglimento in quella che viene definita “Sindrome rabdomiolitica”. Se punge e non è velenoso, tutta quella
terapia cosiddetta coreutico-musicale-cromatica perché la ricercavano e la
praticavano? E perché, alla fine, le Tarantolate si sentivano perfino guarite? E
se già agli inizi del 1800 il ragno non avvelenava più, perché Oronzo nel 2000
viene curato per avvelenamento da Tarantola?
Dopo quarant’anni sì ma qualcuno se n’è accorto e anche
pubblicamente. Se ne sono accorti gli infermieri. Fu infatti dall’incontro e
confronto di due infermieri che si volle riaprire un momento di riflessione su
un argomento sul quale sembrava essere caduta l’ultima parola. Fu grazie a loro
che alla fine del 2000, a
Lecce, presso un Centro Congressi, e a cura dell’IPASVI (Collegio Provinciale degli Infermieri Professionali, Assistenti
Sanitari e Vigilatrici Infanzia) si organizzò in una giornata di studio il
convegno interdisciplinare “Tarante”: veleni
e guarigioni - 31 ottobre 2000 - a cura di Roberto Pepe (Infermiere e Aracnologo), Michele
Fortuna (Infermiere, Presidente del Collegio
IPASVI di Lecce) e Genuario Belmonte (Zoologo
- Università degli Studi di Lecce).
Come fa oggi il medico a confermare la puntura della Tarantola,
a ritenere quella stessa sintomatologia millennaria, per finire dall’etnologo
ritenuta quella di un ragno simbolico, legata questa volta ad un ragno reale,
con un salto trans-de Martiniano? Non è un atto di lesa maestà? Come fa il
medico, dopo tutto quello a cui un De Martino era pervenuto con la sua
meticolosa ricerca sul campo con un’équipe multiprofessionale, a non vedere più
nella sintomatologia della persona punta una competenza neuropsichiatrica? È
possibile pensare che questa volta non ci troviamo più di fronte a persone
portatrici di un conflitto psicologico irrisolto?
Queste e mille altre domande ancora ci suscitano quelle
persone della Puglia in particolare. Ancora con De Martino non sembra che i
bisogni della Tarantola e dei Tarantolati corrispondessero sempre a quelli dei
loro studiosi che, qualche volta sembra si muovessero in una prospettiva
diversa sia della Tarantola che dei Tarantolati.
Gli infermieri di Lecce sono per noi curiosi la non
conclusiva occasione per un nuovo ciclo di studi e un approfondimento, questa
volta si spera inutile, se non delle persone almeno del fenomeno.
a
cura di
Roberto Pepe
Michele Fortuna
Genuario Belmonte
Atti del Convegno Interdisciplinare
Collegio Provinciale IPASVI Lecce “TARANTE” VELENI E GUARIGIONI
Il libro “Tarante” veleni e guarigioni può
essere richiesto a:
Collegio IPASVI di Lecce
Via Redipuglia no3 Lecce
Tel. 0832/300508 - Fax.
0832/300526
segreteria@ipasvi-le.it
La Redazione